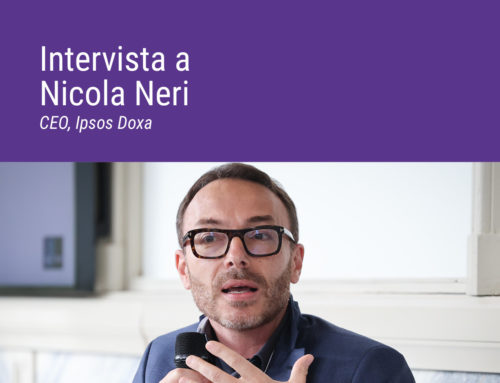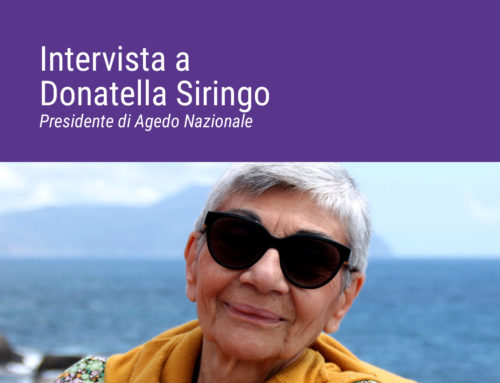Divulgatrice digitale di arte contemporanea e non, Elisabetta Roncati (@artnomademilan sui social) è anche docente universitaria e autrice del volume “Arte Queer. Corpi, segni, storie” edito da Rizzoli. In questa intervista, ci parla dell’importanza dell’arte nell’affermazione dei diritti civili.
D – Siamo abituat* a vedere l’arte soprattutto all’interno dei musei, nel centro città, in contesti dove ne viene valorizzata la bellezza più che riscoperto l’impatto sociale che essa può avere. Eppure, forme d’arte più recenti – come la street art – hanno indubbiamente contribuito a riqualificare spazi urbani degradati. Ci vuoi parlare di questo fenomeno? Che rapporto c’è tra espressione artistica e periferia?
R – L’arte non nasce per essere confinata e anche quando entra nei musei non dovrebbe mai perdere il suo potere di interrogare, disturbare, accogliere, trasformare. In periferia, intesa non solo come luogo geografico ma anche come condizione sociale o esistenziale, l’arte diventa uno strumento potentissimo di riscatto. Penso a murales che raccontano storie dimenticate, a interventi visivi che accendono il dibattito o restituiscono identità a comunità invisibilizzate. La street art, in particolare, ha dimostrato come un linguaggio immediato, accessibile e spesso collettivo possa trasformare muri in specchi: specchi dove vedersi rappresentat* e quindi riconosciut*. In questi spazi l’arte non è ornamento, ma affermazione di esistenza. Un esempio emblematico nella nostra città [Milano, ndr] è il quartiere dell’Ortica con il progetto OrMe, Ortica Memoria, che ha coinvolto tutta la zona già nel 2015: tra le numerose opere nel 2023 è stato realizzato un murales dedicato al tema della legalità in via San Faustino, celebrando figure quali Walter Tobagi, Lea Garofalo, Giorgio Ambrosoli. Anche in altre città italiane questa “energia dal basso” si manifesta in modo potente: ad esempio a Roma (Tor Marancia), a Palermo o a Napoli.
D – Hai recentemente partecipato a un talk, nel contesto delle cosiddette Pride Square organizzate dal CIG Arcigay di Milano, il cui fulcro era “l’artivismo”, ovvero l’arte come atto di resistenza. In che misura e in che modo l’arte può “cambiare” il mondo?
R – Sì, vi ho partecipato assieme a Federica Sutti, l’altra cofounder del collettivo artivistico Artists For Pride che abbiamo creato un paio di anni fa. L’arte non cambia il mondo in modo diretto, ma agisce sulle persone. E sono queste che modificano il mondo. L’artivismo nasce da questa consapevolezza: usare l’arte per resistere, per denunciare, per aprire spazi di possibilità. Non si tratta solo di estetica, ma di etica, di presa di posizione. L’artista “artivista” non si limita a rappresentare la realtà, ma prende posizione su di essa. Durante il talk abbiamo portato esempi di pratiche artistiche che parlano di corpi queer, di razzializzazione, di marginalità, di intersezionalità: sono atti che sfidano le norme e aprono crepe nei sistemi. Piccole “aperture” da cui può filtrare una nuova luce.
D – Parliamo ora, più specificatamente, di chi ha usato il mezzo artistico per affermare i diritti della comunità LGBTQI+. Ci puoi citare i nomi e l’operato di artist* che, attraverso la loro arte, hanno esplorato i temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale?
R – Potrei fare centinaia di nomi, ma provo a scegliere alcun* artist* che per me sono emblematici e che ho inserito nel volume “Arte Queer. Corpi, segni, storie” che ho scritto per Rizzoli Editore. Penso, ad esempio, a David Wojnarowicz, artista e attivista newyorkese che ha vissuto sulla propria pelle l’emergenza AIDS negli Anni Ottanta e ha trasformato l’arte in uno strumento di denuncia, rabbia e visibilità. I suoi lavori mescolano fotografia, scrittura, pittura e performance art per parlare di esclusione, dolore, amore e resistenza queer. Oppure a Zanele Muholi, fotografa e attivista sudafricana, che ha creato un vero e proprio archivio visivo della comunità nera LGBTQI+ in Sudafrica. Le sue serie fotografiche, come “Faces and Phases” restituiscono dignità, bellezza e forza a corpi altrimenti invisibilizzati, decostruendo stereotipi e offrendo una potente contro-narrazione.
D – Un’ultima domanda, forse un po’ provocatoria, che parte dal titolo del tuo libro edito da Rizzoli: esiste un’arte prettamente queer?
R – Esiste un modo queer di guardare, di narrare, di creare. Non è tanto una questione di etichetta quanto di prospettiva. L’arte queer non si definisce solo per chi la produce o per i temi che affronta, ma per come sovverte le norme di genere, di sessualità, ma anche di linguaggio artistico. È un’arte che destabilizza, che ibrida, che contesta il binarismo e rifiuta l’idea di una sola verità. È un’arte che mette in discussione lo sguardo dominante e costruisce alternative. In questo senso, sì: esiste un’arte queer, ma non va ingabbiata. Va vissuta, attraversata, lasciata fluire.